persone da una parte all'altra.
A differenza del periodo antico, ci furono però delle problematiche legate alle invasioni barbariche.
Le vie di terra
II succedersi delle
invasioni barbariche, a partire dal V-VI secolo, rese insicure le comunicazioni
terrestri in tutta l'area dell'Impero Romano in disfacimento. Nonostante i
danni derivanti dalla mancanza di manutenzione, i traffici via terra
continuarono a fruire anche nel medioevo della stupefacente rete stradale
realizzata dai Romani per fini strategici e commerciali. La sua estensione è
ben rappresentata nella Tabula Peutingeriana, una delle più antiche carte
geografiche esistenti.
Dove la rete stradale rimase in discreta efficienza, i
trasporti continuarono ad avvenire utilizzando carri molto simili a quelli in
uso in epoca romana.
Quando l'uso dei carri non era possibile, i traffici
avvenivano con l'uso di cavalcature, di regola
riservate al movimento di persone di elevato ceto
sociale ,ma gran parte del movimento di persone e cose
avveniva, verosimilmente, attraverso lunghi e
pericolosi spostamenti a piedi.
Le vie d'acqua
La difficoltà di utilizzare i percorsi terrestri rese
necessario per quasi tutto il medioevo il ricorso
alle vie d'acqua per i trasporti di persone e cose.
Non che esse fossero immuni da ostacoli e
pericoli; tuttavia risultavano meno onerose, più
dirette, almeno dove vi fossero il mare o fiumi
navigabili, e con rischi almeno in parte più
limitati. Le vie d'acqua interne erano solcate da
imbarcazioni di piccola dimensione.
I trasporti sulle più lunghe distanze marine,
anche se effettuati mediante piccolo cabotaggio,
richiedevano barche di maggior dimensione,
derivate dalle romane navi onerarie, che
trovarono una loro efficiente espressione
nell'epoca delle città marinare nella nave tonda o
cocca.
Queste navi, adatte al trasporto di merci nell'area
mediterranea, avevano propulsione a vela il che
le rendeva soggette allo spirare dei venti. Una
valida alternativa a queste imbarcazioni furono
per molti secoli quelle con propulsione mista a
remi e a vela, cioè le galere. Nate per esigenze
militari, furono utilizzate dai veneziani anche per i
convogli commerciali, le cosiddette "mude", verso
i porti dell'oriente e verso quelli atlantici.
Le galere furono utilizzate da tutte le marinerie
del Mediterraneo, dai Bizantini ai Turchi, dal
papato ai granduchi di Toscana, dai genovesi agli
spagnoli e all'Ordine di Malta.
Nello stesso periodo, nel nord Europa i popoli
vichinghi svilupparono un'imbarcazione a
propulsione mista (remi e vela) che consentì la
loro affermazione militare e commerciale: il
drakkar.
Dalle navi tonde si svilupparono verso la fine del
medioevo e all'inizio del rinascimento
imbarcazioni di sempre maggior dimensione,
adatte al commercio anche sulle rotte oceaniche:
le caracche, le caravelle e, infine, i galeoni.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/LsyZS0Co0jXvFS8VaLKsOWiWQzEDt
AIy7WAz5veYUTlEtd4lD09Gf4g4876GVTkXU41QaDC6-07Lr6PmDMALhkWMx4o2HtOLt9DybXaLh3W4IGRuNBgHRY0
Essenziale per lo sviluppo dei trasporti marittimi
fu l'introduzione di nuovi e più evoluti strumenti di
navigazione, soprattutto la bussola e l'astrolabio,
mentre venivano migliorate le rappresentazioni
del mondo e le carte nautiche.
Senza questi strumenti di navigazione i trasferimenti sarebbero stati impossibili.

https://www.acilsestante.it/astronomia/scuola/descalzo/colombo/foto/b03_bussola.jpg
https://www.larucola.org/wp-content/uploads/p-10-11-Astrolabe-Karolingisch-front600.jpg
Non c'è stato dunque un passo avanti radicale per quanto riguarda i trasporti , ma le innovazioni navali sono state notevoli, tanto da permettere la navigazione verso nuovi continenti e la conseguente scoperta dell'America.







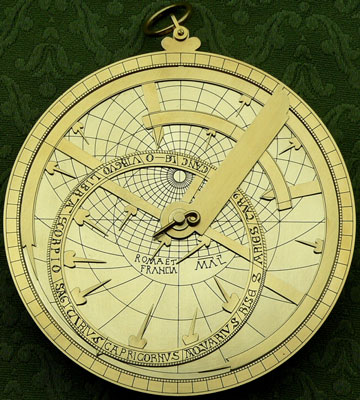

Nessun commento:
Posta un commento